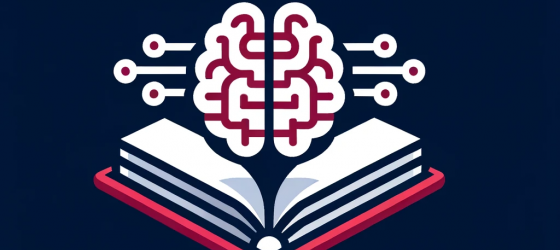Call for Abstracts (DH2025)
Connessioni Digitali: Linguaggi, Arti, Culture e Tecnologie in Dialogo
26-27 Giugno
Università degli Studi di Genova
Le Digital Humanities (DH) rappresentano un'area di studi che si colloca all'incrocio tra metodi computazionali e riflessioni teoriche proprie delle scienze umane e sociali (Ramsay, 2013), proponendo un uso sistematico dei metodi digitali e una riflessione critica sulla loro applicazione alle scienze umane e sociali. Rimandando al manifesto delle Digital Humanities prodotto nell’ambito della “non-conferenza” THATCamp tenutosi a Parigi nel 2010, le DH vengono ulteriormente presentate come un modo per formare una comunità interdisciplinare e multilingue connessa globalmente (Mounier, 2010).
Questo campo, inizialmente di nicchia, è diventato un movimento scientifico di primaria importanza e visibilità, segnando una trasformazione profonda nel panorama accademico e culturale globale. In occasione di un incontro organizzato dalla Association for Literary and Linguistic Computing nel 2002, Harold Short e Willard McCarty hanno sottolineato l'importanza di un modello di methodological commons, ossia un insieme condiviso di tecniche e pratiche digitali applicabili trasversalmente alle discipline umanistiche. Nel modello da loro elaborato, tali methodological commons includono metodi tecnici interdisciplinari, nuove collaborazioni tra scienze e discipline umanistiche e sociali, combinazioni di dati e tecnologie, analisi formale dei dati e gestione di fonti su larga scala (Hughes, 2015).
Data la loro natura, dunque, le Digital Humanities sono considerate come una galassia multidisciplinare (Ciotti, 2023), una metafora che ne sottolinea la varietà di esperienze scientifiche e didattiche. Patrick Svensson, nel suo Big Digital Humanities (2016), amplia questa visione introducendo il concetto di “infrastruttura”, intesa sia come piattaforma operativa che come spazio intellettuale per favorire il dialogo tra digitale e umanistico. Le Digital Humanities rappresentano uno scambio reciproco e proficuo tra le scienze umane e sociali e le tecnologie digitali, il quale ha contribuito attivamente anche al progresso del panorama tecnologico introducendo approcci critici e riflessivi. Esempi significativi includono le prospettive femministe e postcoloniali, che mettono in luce i bias insiti nelle tecnologie digitali e decostruiscono la loro apparente neutralità (Risam, 2018). Al contempo, il dibattito etico intorno all’intelligenza artificiale, come evidenziato in recenti rassegne critiche (Prem, 2023), sottolinea l’urgenza di un dialogo interdisciplinare per costruire un futuro tecnologico più inclusivo e consapevole.
L’avvento delle tecnologie digitali ha modificato, e continua a modificare, le metodologie comuni alle Humanities generando nuovi punti di incontro tra le diverse discipline umanistiche. Un incontro reso possibile grazie a strumenti come Machine Learning (ML), Natural Language Processing (NLP), Large Language Models (LLMs), profondamente interdisciplinari e applicate in molteplici contesti; Virtual Reality (VR) e Mixed Reality (MR) per il campo artistico o educativo; o ad approcci come distant reading (Moretti, 2000), scalable reading (Jockers, 2013) per l’analisi della letteratura, la traduzione automatica, il Technology Enhanced Learning (Timmis et al., 2015) per l’ambito educativo.
Visto quanto detto finora, il convegno si propone di esplorare non solo come gli strumenti digitali abbiano trasformato radicalmente le pratiche e le possibilità nella ricerca umanistica, ma anche come gli approcci critici e riflessivi dell'umanista influenzino le scienze dell’informazione e della comunicazione (ITC). Questo scambio bidirezionale invita a riflettere sulle trasformazioni e sulle connessioni che tali dinamiche generano nell'arte, nelle lingue, nelle culture e, più in generale, nelle discipline umanistiche.
I partecipanti sono invitati a contribuire con interventi riguardanti i seguenti tre ambiti di ricerca e le relative tecnologie e metodologie ad essi legate:
- Tecnologie multimediali e digitalizzazione per arti, spettacolo e patrimonio culturale: trasformazioni nei processi di produzione e ricezione di opere artistiche e multimediali, tecnologie digitali per la digitalizzazione e la conservazione e fruizione del patrimonio artistico, linguistico, architettonico, documentale, archivistica, arti performative, musei virtuali.
- Tecnologie e metodi computazionali per la linguistica, le letterature e le culture: translation studies, lessicografia, semantica, sociolinguistica, onomastica e toponomastica, multilinguismo e interferenze linguistiche, analisi dei testi tramite IA, big data, NLP, linguistica dei corpora, computazionale e applicata, analisi delle opere letterarie ed estrazione di informazioni dai testi con approcci digitali (scalable reading).
- Tecnologie didattiche e ambienti di apprendimento digitali: strategie didattiche per l’apprendimento, nuove tecnologie per la didattica e intelligenza artificiale, game-based learning, pedagogia speciale, didattica museale.
Le giornate dottorali saranno inoltre arricchite da keynote speaker italiani e internazionali a livello teorico, metodologico e applicativo con interventi di prestigio afferenti agli ambiti di ricerca sopracitati.
La Call for Abtracts è scaricabile al seguente link: https://digitalhumanities.phd.unige.it/sites/digitalhumanities.phd.unige.it/files/2025-03/Call_for_Abstract_2025.pdf
La scadenza per l'invio è il 10 marzo 2025 30 marzo 2025.